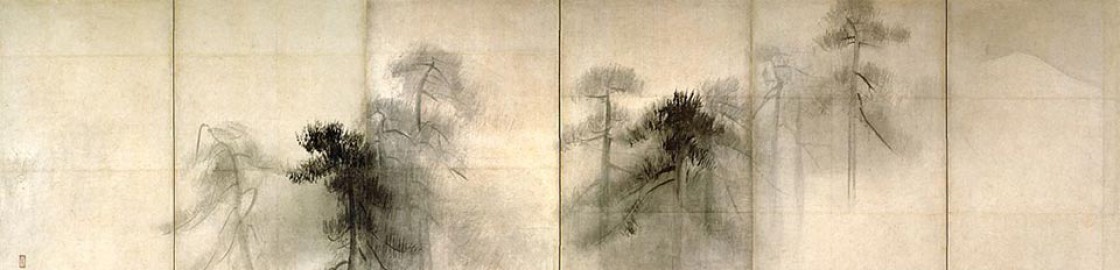La passione di Dodin Bouffant (Benoit Magimel) non è un segreto. Viene rivelata fin dalla maestosa, prolungata sequenza di apertura, quaranta minuti di danza tra piastre e pentole fumanti in cui la cuciniera Eugénie (Juliette Binoche), alzata al crepuscolo mattutino, eviscera il pesce, inforna le meringhe, filtra le salse, rosola il bue, attende alle preparazioni del carré d’agnello, del vol-au-vent, del rombo affogato, dell’omelette alla norvegese in una coreografia di carni che sfrigolano, brodi che sobbollono, stoviglie che cozzano, tutto per il pranzo pantagruelico del gourmand Bouffant, il “Napoleone della gastronomia”, e della sua corte epicurea di affiliati, amici, avventori.
La passione di Dodin Bouffant oscilla tra la cucina e la camera da letto della cuciniera Eugénie, che gli fa trovare la porta a volte chiusa a volte aperta. Una storia d’amore matura per i tempi (siamo a inizio Novecento), matura nell’età degli amanti, e che pure gioca a fingersi acerba. È la stessa Eugénie a rifiutare di sposarlo, “per essere sicura di poter tenere la porta chiusa quando ne ho voglia”. I dialoghi sono pochi e comunque meno eloquenti degli sguardi, e gli sguardi meno eloquenti dei gesti nel cinema aptico di Ahn Hung, che svuota la storia di azione e parole per riempirla di mani, di gesti, di aromi materializzati dal montaggio che stacca dai fumi della cucina a Dodin che li avverte sin dalla vasca da bagno, del concerto appetitoso degli utensili che si rispondono in un film quasi interamente privo di colonna sonora.
La passione di Dodin Bouffant segue il moto intossicante della macchina da presa che sembra voler inseguire gli sguardi languorosi degli amanti, sembra voler scoperchiare le pentole e sfiorare le pietanze. La ritroviamo nel montaggio eisensteiniano che accosta il corpo sinuoso di una pera glassata al nudo di Juliette Binoche, accostando gastronomia ed erotismo al ritmo di una lenta, meticolosa scoperta che si rinnova di pasto in pasto, di morso in morso. La battuta più significativa dell’intero film, pronunciata da Dodin, allude proprio a questo: “Amo tutte le stagioni. Le prime gocce di pioggia, i primi fiocchi di neve, i primi fuochi nel camino, i primi germogli. Tutte queste prime cose che ritornano mi riempiono di felicità”.
“La passione di Dodin Bouffant” si innesta con questo senso pungente di caducità nel filone cinematografico del “gastromanticismo” che annovera titoli importanti come “La grande abbuffata”, “Il pranzo di Babette”, “Il cuoco, il ladro, la moglie e l’amante”, “Chocolat”, “Tampopo” e “Il filo nascosto”. Proprio quest’ultimo offre un intrigante parallelo: là la relazione di coppia si dava come avvelenamento volontario, duello a fasi alterne che riposa sulla costante alternanza di dominante e dominato; qui si dà come rapporto paritario di cura e scambio quotidiano, che dilata il gesto e il momento in apprezzamento intenso di una temporalità dove gli odori, i gusti, diventano sculture sensoriali incarnate nella fisicità delicata e statuaria dei due interpreti – che amanti, oltre che nello schermo, lo furono nella vita – la grazia infinita di Juliette Binoche, il fascino lunare di Magimel.
Questa calma sensualità persistente, come l’odore del brodo che riempie la stanza, ricorda il cinema di Wong Kar-wai, di Nagisa Oshima, e già ne avevamo avuto un assaggio nel magnifico esordio, “Il profumo della papaya verde”. L’accostamento tra cinema e gastronomia viene naturale – diversi “ingredienti”, una complessa “ricetta”, il “gusto” di un autore, il “retrogusto” che lascia un film – ma qui è quasi una dichiarazione d’intenti: la sottotrama principale racconta del menù che Dodin vuole offrire al principe di Estonia, con piatto principale il pot-au-feu, che doveva anche essere il titolo del film. Piatto umile, generoso, di carni e verdure bollite, che ha sfamato le generazioni di Francia.
Umiltà e generosità sono anche gli ingredienti principali del cinema di Anh Hung, che cuoce a fuoco lento e affida il finale a una panoramica circolare su una cucina vuota, con i fantasmi della memoria che tornano a imprimersi sulla luce calda, deliquescente del pomeriggio, un po’ come le immagini sulla pellicola in un celebre carrello di Mizoguchi (Ugetsu), prima che esploda la sola e unica traccia musicale del film, la Méditation di Massenet. “Ti ricordi questo sapore?” aveva chiesto Dodin alla giovane allieva Pauline certificando il rapporto che esiste tra gusto e memoria (Proust docet). Proprio nella memoria, attraverso la liturgia vaporosa dei gesti ripetuti e ritualizzati, la cerimonia del cibo trova la sua celebrazione, riconnettendo passato e presente in un istante senza tempo. Gustare equivale a fotografare con le labbra, con i sensi, rubando spiccioli di vita dalle mani avare del tempo.
Guardatelo a stomaco pieno.
★★★★☆