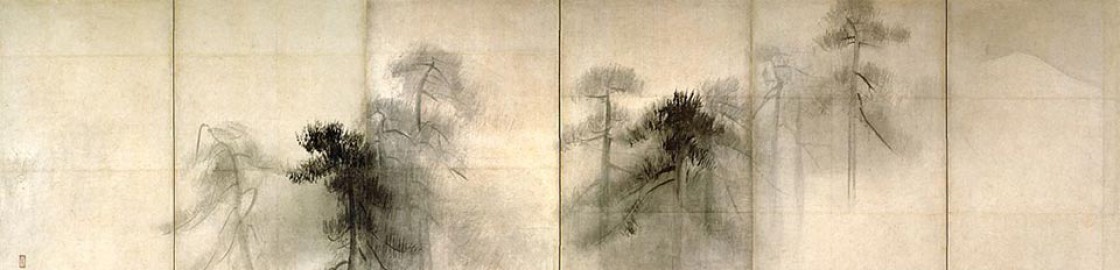Commentando i pronostici degli Oscar 2025, Anna Maria Pasetti del Fatto quotidiano scrive che “le chance di The Brutalist sarebbero dovute aumentare. E invece si è avvertita un’inversione di tendenza a penalizzare questo titolo. Contestualmente si sono rafforzati i favori per il pseudo-indie e sopravvalutato Anora che, oltre all’inspiegabile Palma d’oro all’ultimo festival di Cannes, si è portato a casa il significativo Directors Guild Award, cioè il premio attribuito a Baker proprio dai colleghi”.
Peccato che Pasetti spenda più parole a sminuire una cinematografia così originale come quella di Sean Baker che a illuminarne i punti di forza. In realtà non credo che sia così “inspiegabile” il successo di Anora, né dal punto di vista del valore del film né da quello delle logiche di produzione e promozione che spesso stanno dietro alle scelte degli Academy. Comunque, a seguire due o tre cose che so di lei – Anora – e sulla filmografia di Baker.
Dropout. I personaggi di Baker sono tutti o quasi tutti dropout, figure tipiche del cinema americano: coloro che cadono fuori (drop-out) dalle rappresentazioni convenzionali della società, che non hanno un ruolo definito e vivono per varie ragioni ai margini del contratto sociale, non solo dal punto di vista economico ma anche di status. Travis Bickle/De Niro in Taxi Driver di Scorsese appartiene a questa categoria, così come il Gazzarra di Killing of a Chinese Bookie di Cassavetes. In Baker sono quasi sempre personaggi femminili, madri single o transessuali, spesso coinvolte nel mercato del porno o della prostituzione.
Fine delle illusioni. L’ex pornodivo protagonista di Red Rocket (che avevamo elogiato in pochi) pedala sognando Hollywood mentre sullo sfondo scivolano senza far rumore i killing fields texani, dove sono stati ritrovati decine di corpi di giovani donne, omicidi mai risolti. La madre single che si prostituisce protagonista di Un sogno chiamato Florida vive a poca distanza da Disney World, Orlando. Anora è una giovane immigrata newyorkese di seconda generazione che entra in contatto con il mondo lussuoso e transnazionale degli oligarchi. I personaggi bakeriani non sono soltanto testimoni delle contraddizioni del sogno americano. Sono essi stessi sognatori in bilico tra mondi opposti che sono sostenuti proprio dalla loro reciproca opposizione. Spesso sull’orlo di un brusco risveglio. Come si fa a non volergli bene?
Tradizione. La critica dell’American Dream, la figura del dropout, l’interesse etnografico per luoghi marginali e abbrutiti dalla miseria non sono certo novità nel cinema americano. Diventano anzi temi prominenti negli anni ’70, dove la corrente New Hollywood, in opposizione agli ambienti patinati e altoborghesi descritti dalla Classic Hollywood, inaugura con registi come Scorsese, Friedkin e Cassavetes una stagione cruda e realista. Il cinema di Baker si rifà anche tecnicamente a quella stagione, rivisitandola secondo i crismi della commedia o comunque della dramedy. Un cinema di viraggi forti, montaggi netti, ma anche di fluidi piani sequenza e ondeggianti camere a mano, con un profumo artigianale.
Innovazione. Questa perizia artigiana, che più che un’innovazione è un ritorno all’origine, rappresenta un elemento distintivo del cinema di Baker, che non è solo padre ma anche padrone delle immagini, capace di ricondurre a uno stile personale e inconfondibile sequenze rese anarchiche da una buona dose di improvvisazione (in Anora, poco). Ancora più originale e tipizzante la tendenza a dar voce a una categoria marginale e sfruttata come quella delle sex workers, discorso che in Baker si ammanta con i vestiti dello spettro marxista e infesta con pestifera ma spietata veemenza la retorica del sogno americano, rivelando l’inscindibile e crudele commistione di rapporti economici, rapporti sessuali e rapporti sociali sotto un velo di ironia feroce.
Oscar e Palma. Per comprendere i premi bisogna innanzitutto sollevare quel velo – fermo restando che l’Oscar come e più di ogni premio non è garanzia assoluta di qualità. Con questa scelta, Hollywood conferma il trend arty e inclusivo degli ultimi anni: dopo Oppenheimer, Everything Everywhere All at Once, Nomadland, Parasite, La forma dell’acqua, vince un altro film “autoriale” (qualunque cosa significhi), che si distingue per una certa radicalità dello stile (oppenheimer, i nominati brutalist e the substance) e un senso di inclusività diretto talvolta verso altre tradizioni etno-culturali (eeao, parasite), talvolta verso una generica categoria di “emarginati” (nomadland, forma dell’acqua, anora). In sintesi, Hollywood tende la mano a un altro tipo di cinema, quel cinema che in Hollywood abitualmente non si identifica. Non una casualità: chi apprezza l’arte poi riesce anche a riprodurla (e a guadagnarci).
Intanto Sean Baker, con il suo film più dolce, anche in termini di stile (il più “digeribile”), corona con l’Oscar una filmografia audace, coerente e provvista di un’identità specifica. Esattamente quello che non è riuscito a fare Brady Corbet con The Brutalist (che ho recensito qui). Non so se è abbastanza per spiegare il successo di Anora, ma da qui a inspiegabile ce ne passa.