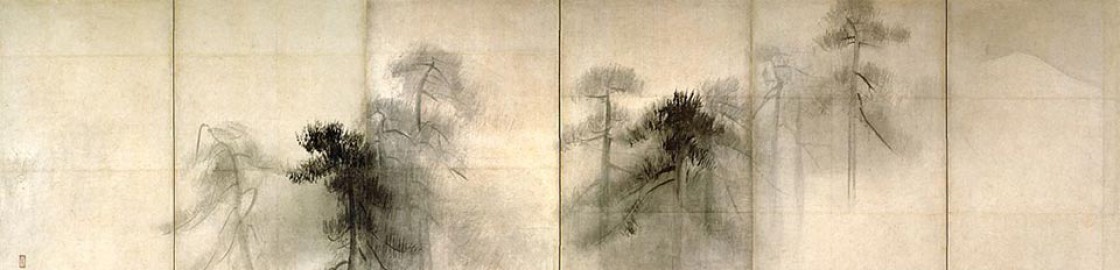Un commento in memoria di David Lynch.
Lo specchio – Dualità
Fuoco e acqua, notte e giorno, sole e luna, uomo e donna, freddo e caldo, sopra e sotto, male e bene, bianco e nero, sì e no, destra e sinistra, sempre e mai, passato e futuro, luce e buio, veglia e sogno, vita e morte, lo specchio e il suo riflesso. Sin dalle prime ore di vita, un essere umano comincia a orientarsi in una realtà complessa, dinamica, in perpetuo movimento, e lo fa operando differenze e distinzioni che spesso si basano su coppie di opposti complementari. Per questo il cinema di Lynch colpisce così in profondità. È zarathustriano nel suo profetizzare una realtà costruita, ancora prima che animata, da polarità oppositive in uno stato di lotta perpetua.
Un cinema eracliteo, e verrebbe da dire che il fuoco è il simbolo principale nella poetica di Lynch. Invece no, è lo specchio. L’occhio dello specchio ha il potere inquietante di duplicare qualsiasi cosa incontri il suo sguardo. Le singolarità del mondo raddoppiano, si moltiplicano, si invertono di segno. Lo specchio materializza la doppiezza di ciò che appare unico, unitario, indivisibile. L’umanità di Lynch è sempre in procinto di sfaldarsi, di scindersi, lacerata da impulsi e appetiti contrapposti. Lo specchio allora è uno strumento per cogliere la verità del reale nel suo riflesso fasullo, il suo inerente, incombente dividersi in una dualità discorde, violenta. Twin Peaks: i picchi gemelli. Doppi, appunto.

La stanza – Chora
Nel Timeo, Platone per giustificare l’esistenza delle forme reali ipotizza l’esistenza di un luogo metafisico, un intervallo, un ricettacolo, grembo o matrice, dove queste forme vengono accolte e generate, dove i confini invalicabili della realtà diventano flessibili e porosi, il sogno si confonde con la veglia, la vita con la morte. È la Chora (χώρα). Il cinema di Lynch è pieno di chorai. La stanza rossa di Twin Peaks, il Club Silencio di Mulholland Drive, l’appartamento di Dorothy Valley in Velluto blu, la casa dei Madison in Strade perdute… luoghi in cui l’eccezione soverchia la regola, e gli schemi della natura si piegano alle logiche del soprannaturale.
La chora, scrive Platone, è un “terzo genere” (triton genos). Laddove la dualità è alla base del concetto stesso di differenza, perché ciò che non è identico a sé stesso è qualcos’altro, dunque non-A implica sempre B, il “terzo genere” della chora è invece il non-luogo dove la dualità si placa, dove i contrasti si riconciliano, dove i personaggi di Lynch possono immergersi per recuperare il senso completo di una totalità spezzata, fratturata, scissa. Come Cooper nella stanza rossa tra i velluti rossi, o Betty/Diane nella stanza da letto, quando usa la chiave blu per aprire la scatola blu, che funziona come un’altra stanza, un’altra chora. Stanze che sollevano momentaneamente i velluti che nascondono l’abisso per permettere all’abisso di entrare.

L’uovo – Endice
Se il cosmo lynchiano è manicheo, duale, questa dualità si condensa e manifesta in una serie virtualmente infinita di segni, a loro volta incarnati in immagini: il fuoco, la luce elettrica, i tagliaboschi, le civette, il velluto, il nano, lo specchio, la stanza e tanti altri. Seguendo la semiotica di Peirce, i segni di Lynch non sono perlopiù né icone, né simboli. Sono indici, cioè segni che presentano una connessione di carattere fattuale con l’oggetto che rappresentano (la connessione nel caso delle icone è data da una somiglianza, nel caso dei simboli da una convenzione). Questa fattualità però non ha il carattere della realtà ma piuttosto quello della surrealtà; così uno specchio non indica solo la presenza reale di un riflesso ma la presenza surreale di una scissione, la stanza non indica solo la presenza reale di uno spazio ma la presenza surreale di uno spazio interiore o metafisico, e così via.
Gli “indici” lynchiani raramente definiscono una relazione univoca con un significato. Più spesso sono significanti in cerca di significato. Benché concreti, tangibili, triviali – un’abbattiluce, una scatoletta, una civetta – rimandano alla presenza sottesa e intangibile di significati nascosti, contraddittori. Le immagini di Lynch condividono con la poesia la capacità di offrire “universali concreti” (critica letteraria di Wimsatt), cioè di incarnare l’unione ossimorica di oggetti specifici, banali e concetti astratti, intangibili, come le foglie di Ungaretti. Rispetto ad altri registi che amano surrealismo e allusività, la particolarità di Lynch è che non si limita a mostrare al pubblico un puzzle di segni, ma offre sempre al pubblico una chiave per la sua risoluzione. Malgrado il deragliamento, talvolta incomprensibile, del treno della realtà, la forza del cinema di Lynch risiede nel non cedere all’arbitrarietà dei segni, ma nell’offrire mappe incomplete, rovinate, imprecise, misteriose, eppure sempre animate da un altissimo grado di coerenza interna. Una rigorosa vaghezza.

Comprendere il cinema di Lynch non comporta semplicemente decifrare i segni, ma raccogliere gli indici sparsi sulla mappa e lanciarli come dadi per rimettere in gioco segni profondi come abissi, come chorai, che non smettono mai di accogliere e partorire nuovi significati, nuove suggestioni, in un perpetuo rispecchiarsi di allusioni e illusioni. Allora si può anche pensare che la chiave semiotica per comprendere Lynch non sia l’indice, bensì l’endice. Nella definizione Treccani, l’endice è un “uovo di marmo, o vero, che si mette nel nido delle galline perché vi ritornino a far le uova”, ovvero un segno che non indica un significato ma ne produce uno. Ecco, il cinema di Lynch non è un cinema di indici ma un cinema di endici, segni illusori, segni allusivi, segni che non indicano una corrispondenza ma ne producono una. È il pubblico che deve fare l’uovo.*

* Tutto questo tralasciando la centralità simbolica che hanno uova e uccelli nel cinema di Lynch, dalle civette che non sono quello che sembrano all’uovo che rappresenta l’Uno che genera i Molti, la mente “uovica” dell’alchimista che trasforma in oro il piombo, l’anatra che depone le uova d’oro che ricorrono in Twin Peaks, per non parlare della concezione “maieutica” della verità intesa come verità soggettiva, personale, che rimanda alla metafora incorporata della gravidanza – ma questa è un’altra storia.