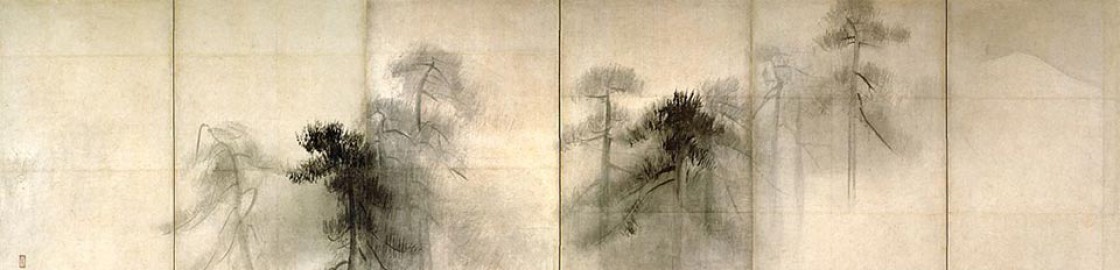La rivoluzione è sempre per tre quarti fantasia e per un quarto realtà
Bakunin

1. Storia e realtà
Strutturiamo l’analisi intorno a questa citazione di Bakunin, partendo da quello spicchio di rivoluzione, quel quarto, quel 25%, che non può essere altro che la Storia, quella con la S maiuscola, base di partenza per un’allegoria neanche troppo nascosta dell’America di questi anni, scossa dal trumpemoto, lacerata da conflitti razziali, attizzata da logge suprematiste che operano alla luce del sole, resa fragile e incupita da politiche sociali, quelle neoliberiste, che hanno esasperato le polarità e le disuguaglianze. Difatti il film si apre con un personaggio, e un nome – Perfidia Beverly Hills – che rivela, come spesso accade nella toponomastica andersoniana, temi e suggestioni latenti: Beverly Hills è dove vivono le star di Hollywood, tra i luoghi più ricchi del pianeta, e Perfidia è contemporaneamente l’imposizione neoliberista di tale modello economico e la reazione delle masse indigenti a fronte di tanto squilibrio.
Mentre tanti altri registi, l’ultimo dei quali è Ari Aster con Eddington, ma anche Alex Garland con Civil War, rimangono su un piano strettamente allegorico o distopico approcciando con più o meno ironia il genere della satira, PTA tende come suo solito al pastiche, il genere postmoderno per eccellenza dato che indica la mescolanza di tutti i generi. Anche se One Battle After Another (OBAA) è soprattutto un film d’azione, troviamo in Di Caprio e soprattutto Del Toro due maschere da commedia, la prima più da fratelli Coen e la seconda più da Wes Anderson (altro autore che ha da poco realizzato la sua satira sul regime neoliberista); troviamo nel deserto una tipica ambientazione Western; troviamo nelle tematiche una deriva drammatica, nelle vicende narrate un’inclinazione fantascientifica. Come scriveva Jameson, il papà teorico del postmoderno, il genere postmoderno è marcato da “il cannibalismo casuale di tutti gli stili passati, il gioco dell’allusione di stile arbitraria, della dimensione retrospettiva indispensabile a ogni ri-orientamento vitale del nostro futuro collettivo – è divenuto nel frattempo una vasta collezione d’immagini, un affollato simulacro fotografico” [the random cannibalization of all the styles of the past, the play of random stylistic allusion, retrospective dimension indispensable to any vital reorientation of our collective future – has meanwhile itself become a vast collection of images, a multitudinous photographic simulacrum].
Cosa rimane allora della Storia generale in questa storia particolare che è OBAA?
2. Fantasie di Potere
Perfidia (Taylor), la pasionaria che guida French 75 alla battaglia e poi scompare dalla vita pubblica e anche da quella privata, familiare, che la lega a Ghetto Pat (Di Caprio) e alla neonata figlia Willa (Infiniti), incarna l’utopia, il sogno rivoluzionario, il luogo e la società che non esiste ancora, e difatti rimane irragiungibile da tutti i personaggi che, in un moto forsennato, ariostesco, si sforzano di catturarla: lo stesso Ghetto, la stessa figlia, e il colonnello Lockjaw (Penn) che rappresenta la pulsione opposta e contraria a Perfidia, un principio d’ordine, gerarchia e stabilità.
Tutti i film di PTA raccontano conflitti di potere, spesso attraverso famiglie surrogate o disfunzionali: la famiglia è la più elementare struttura di potere, l’atomo del potere. OBAA non fa eccezione. Intorno al vuoto strutturale lasciato da Perfidia si muovono vanamente vari personaggi cercando di riempirlo. Ghetto, adulto e ormai rassegnato, imbolsito, fiaccato dalle droghe, è il simbolo della generazione adulta che ha perso la forza e la fiducia nel cambiamento. Lockjaw, motivato da ideali gerarchici, repressivi e violenti, manifesta le forze visibili (esercito) e invisibili (massoneria) che agiscono in nome di un’utopia elitaria, esattamente il contrario dell’utopia egalitaria per cui si batte Perfidia. Willa infine rappresenta la forza e la speranza delle nuove generazioni che lottano per il cambiamento e lotteranno finché non diventeranno adulte, per poi consegnare la fiaccola della lotta alla generazione successiva.
Se Lacan definisce nome-del-padre l’operatore che assolve una funzione legislativa, proibitiva, autoritaria all’interno delle dinamiche psichiche, qui potremmo piuttosto parlare di nome-della-madre, ovvero Perfidia, che tramite la propria assenza impone alle identità che la circondano di strutturarsi intorno a quel vuoto che lei stessa ha creato. Ecco allora Lockjaw, che alla plain-view del Petroliere e al fallo eretto, anzi di legno, wood-cock del Filo nascosto, aggiunge un ulteriore dettaglio, la mascella serrata di un coccodrillo, lock-jaw, alla galleria di personaggi paterni e autoritari disegnata da PTA. Sean Penn, che gioca tantissimo proprio con la mimica facciale in questa prova magistrale, incarna il SUPEREGO, ovvero l’internalizzazione dell’autorità paterna, mentre Di Caprio manifesta invece l’ID, la componente istintuale guidata dal principio di piacere che cerca immediata gratificazione. Questo conflitto non è nuovo affatto nella filmografia di PTA (Phoenix vs. Seymour Hoffman in The Master; Doc vs. Bigfoot in Inherent Vice…). A Willa rimane il ruolo dell’EGO, e infatti è chiamata a scegliere tra due padri antipodici e antagonisti nel percorso di costruzione della propria identità. Non sono quindi i padri a riconoscere i figli ma i figli a riconoscere i padri. Il riconoscimento però necessita non di una traccia biologica quanto ideologica: questo il senso della scena in cui Willa, con la pistola in mano, intima a Ghetto di pronunciare le parole d’ordine rivoluzionarie. La condivisione di valori, ideali, conta più del sangue, anche nei rapporti familiari. La storia di ogni famiglia infatti è la storia di una rivoluzione, perché i rapporti di potere gradualmente si invertono e i padri invecchiando diventano, per dirla alla Gordon Gekko, “le ossa su cui i figli affilano i denti”.

3. Fantasie cinefile
Cominciamo dalla più evidente perché è una citazione dichiarata, quella del capolavoro di Gillo Pontecorvo La Battaglia di Algeri, film del 1957 che viene non soltanto mandato in onda nel salotto di Di Caprio, ma sembra anche ispirare il nome dell’organizzazione rivoluzionaria French 75 – francese, come la dominazione sull’Algeria, e 75, come l’anno di uscita del film di Pontecorvo al contrario. Per il resto, come dice bene l’amico e collega Giuseppe Gangi su ondacinema, PTA cuce la cinefilia nel tessuto audiovisivo occultandola come fa Reynold Woodcock con i suoi abiti di sartoria nel Filo nascosto, invece di esibirla ammiccando come ad esempio preferisce fare Tarantino.
La battaglia di Algeri viene recuperata anche nella costruzione degli ambienti urbani durante la guerrilla, mentre le architetture militari e massoniche dei Xmas Adventurers ricordano piuttosto i volumi architetturali di Pakula, vasti, simmetrici e incombenti come l’autorità che manifestano. Il personaggio di Penn è una chiara parodia dell’autoritarismo militare usa, incarnato al cinema da personaggi come il generale Turgidson di Strangelove o il generale Patton, entrambi interpretati da George C. Scott con cui Penn ha una inquietante somiglianza. Di Caprio è modellato invece alla Big Lebowski o alla Joaquin Phoenix in Inherent Vice. Il rapporto tra Ghetto e Perfidia ricorda le dinamiche di Bonnie e Clyde di Arthur Penn, un connubio esplosivo di libido, carica erotica, e destrudo, carica distruttiva, che si aizzano a vicenda producendo devastazioni come accade pure in Fight Club (Fincher).
Due influenze sorprendenti sono invece 1) l’altro Anderson, Wes, nel ritratto comico di Ghetto e Sensei (Del Toro), ma anche nel ritmo forsennato, nella colonna sonora incalzante e nelle simmetrie spaziali che sembrano comprimere e dilatare la loro possibilità di azione; e 2) Bullitt, poliziesco con Steve McQueen che secondo molti cinefili racchiude la sequenza di inseguimento in auto più bella della storia del cinema, tra i saliscendi di Frisco.

4. Fantasie di spazi
È nella gestione degli spazi che PTA sfrutta al massimo le potenzialità del medium, esprimendo tutto il proprio talento. In OBAA sembra voler recuperare l’immagine-movimento del cinema classico secondo i crismi della continuità, generando un campo che non appare mai determinato dagli elementi che ne suggeriscono la chiusura, ma costantemente propulso dalla plasticità delle inesauribili carrellate, risucchiato dalla durata reale dei piani sequenza e rilanciato dal montaggio alternato e da giochi continui di dissolvenze, lanciato verso la dissoluzione degli equilibri e delle gerarchie generate dalle stesse immagini, motivato a incontrare la propria eccentricità, il costante traboccare dal proprio senso.
Le tre sequenze magistrali in questo senso sono la sequenza d’apertura che racconta l’infiltrazione di French 75 nel campo militare; la fuga di Ghetto e Sensei tra i meandri urbani; e l’inseguimento finale nel deserto, sequenze spaesanti abitate da spazi eccentrici, non mappabili, dinamici e dispersivi.
Questo movimento altmaniano, votato alla dispersione, alla dépense, è esso stesso una dichiarazione politica che si oppone al moto centripeto e gerarchico che vorrebbe, come dicono i Xmas Adventurers, “controllare i confini per salvare il mondo”. È un cinema che, usando Pontecorvo come materiale archeologico, da una parte dichiara l’impossibilità del cinema di fare politica, e ancora di più, l’impossibilità di fare politica per un’epoca – la nostra – ormai irretita dalle maglie di un edonismo superficiale, di un intrattenimento ubiquo e assuefacente – tema cruciale di un alto grande romanzo postmoderno, Infinite Jest di DFW. Se è vero quello che dice Deleuze, che ogni grande film americano è un remake di Birth of a Nation, OBAA potrebbe concedersi un titolo alternativo – Birth of a Revolution, offrendosi come manifesto sia poetico che metapolitico – di come arte e resistenza civile siano capaci, pur represse, rinchiuse e marginalizzate, di rinnovare i tempi e le forme del vivere.